BASILICA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
Rocca dei Rettori
Posizione. La Rocca dei Rettori sorge nel punto più elevato del centro storico di Benevento.
Storia. I Sanniti furono i primi ad utilizzare il luogo come fortezza, di cui restano un muro di contenimento e tracce di terrazzamenti.
Con il dominio romano la collina divenne un ambiente termale, “castellum acquae”, alimentato da un ramo dell’Acquedotto proveniente dal Serino, recentemente riportato alla luce da scavi archeologici.

Caduto l’Impero Romano, Benevento fu conquistata dai Longobardi nel 570 d.C. che costruirono sul “castellum acquae” un Torrione, che con la “Porta Somma”, costituiva uno dei punti di accesso alla città. A partire dal 771, sotto il duca Arechi II, appariva già come un vero e proprio palazzo fortificato che venne ampliato con nuovi ambienti attorno all’XI secolo.
Nel 1070, finita la dominazione longobarda, con il Trattato di Worms, comincia la dominazione pontificia della città protrattasi quasi ininterrottamente fino al 1860.
Dopo una fase di semiabbandono, nel 1320 papa Giovanni XXII ordinò la costruzione di un Palazzo sul modello della fortezza francese di Carcassone da porre accanto al Torrione al fine di dare una sede prestigiosa ed una difesa adeguata ai suoi rappresentanti in città, detti “Rettori Pontifici”, contestati duramente da una parte dei cittadini che rifiutavano i confini dello Stato Pontificio. Il progetto prevedeva un castrum ed un palatium, recintati da mura e protetti da fossati con tre ponti levatoi, con la funzione di:
- assicurare protezione al rettore, in caso di sommosse cittadine;
- far affluire in città truppe fedeli al pontefice, anche in caso di chiusura delle porte da parte dei rivoltosi;
- contrastare i pericoli esterni.
La costruzione inglobò la porta orientale della città, che venne ricostruita poco più oltre.
Alla fine del XVI secolo la rocca si ampliò con i bracci a sud e sud-est sull’attuale giardino, assumendo così una pianta a forma di “G”, attorno al cortile interno.
A partire dal 1586 venne trasformata progressivamente in carcere, rimasto attivo fino al 1865.
Struttura. Dell’antico castello si conserva attualmente solo il mastio centrale, sottoposto a interventi di restauro tra il 1959 e il 1960, che hanno portato al rinvenimento dell’antica porta cittadina, in corrispondenza dell’androne del mastio.
Funzione. Oggi è la sede della provincia di Benevento e ospita la sezione storica del Museo del Sannio che ripercorre la storia della città attraverso documenti ufficiali d’epoca come le pergamene di Falcone Beneventano e la dichiarazione di Talleyrand della presa di possesso di Benevento.Funzione.
| ORARIO | PREZZO |
Lunedì – Mercoledì – Venerdì:
| Ingresso: gratuito. |
Martedì e Giovedì:
| Prenotazione: obbligatoria. CUP: 3457542984 |
| Apertura Giardini: Lunedì a Domenica:
| Ingresso: gratuito. |
Palazzo Paolo V
Storia. Iniziato verso la fine del XVI secolo sotto il pontificato di Paolo V da cui prende il nome, veniva anche chiamato Palazzo di Città (Palatium Civitatis) e successivamente fu denominato Palazzo Magistrale dal nome della strada principale della città Via Magistrale, attuale corso Garibaldi, all’epoca ancora entro le mura longobarde
Fu restaurato a partire dal 1896, divenendo nel Novecento sede del principale cinema della città, il Cine Vittoria, fino al 1995 circa.
Successivamente il palazzo fu sottoposto a restauro. I lavori, iniziati alla fine del XX secolo, sono terminati nei primi anni duemila.

Funzione. Attualmente ospita spazi adibiti al coworking, un caffè letterario ed aree espositive per mostre, convegni, eventi musicali e culturali.
Al suo interno sono presenti stele, statue, pitture murali e decorazioni e sulla piazza antistante svetta l’obelisco egizio, in granito rosso e con geroglifici, eretto nell’88 d.C., sotto il dominio dell’imperatore Domiziano. Inoltre, nel cortile vi sono numerose lapidi che commemorano figure ed eventi importanti della città. foto
All’interno di alcune sale al piano terra è collocato il Museo delle Streghe.
Il palazzo si può visitare solo in occasione di eventi e mostre.

Janua Museo delle Streghe di Benevento
Unguento, unguento
Portami al Noce di Benevento
Supra acqua et supra vent
Et supre ad omne malo tempo
E’ la formula magica che la strega recita prima di prendere il volo
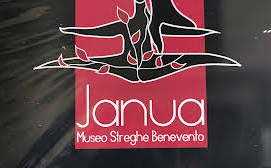
e recarsi al Sabba, per effettuare un rituale consistente in una danza sfrenata in cui è preente Lucifero in persona sotto sembianze di un caprone ed un nutrito consesso di demoni.
Il Sabba, il luogo di ritrovo delle streghe, era collocato sotto un immenso noce, lungo le sponde di un fiume, dove si recavano nelle notti di luna piena.
Quindi, la conformazione geografica di Benevento, che sorge alla confluenza dei fiumi Calore e Sabato, il suo paesaggio collinare ricco di boschi e grotte, nonché la presenza di alberi di noci, nell’immaginario collettivo fece eleggere la città quale privilegiato luogo di incontro di streghe e Janare.
Le streghe, nel contesto di Benevento, sono state spesso considerate come donne dotate di poteri magici, in grado di lanciare incantesimi, praticare la divinazione e interagire con il mondo del soprannaturale.
Le Janare, invece, sono creature leggendarie, spesso rappresentate come donne con ali di pipistrello, in grado di volare e tormentare le persone durante la notte. Il nome potrebbe derivare da Dianara, ossia «sacerdotessa di Diana», dea romana della Luna oppure dal latino ianua, ossia «porta» perché era proprio davanti alla porta, che, secondo la tradizione, era necessario collocare una scopa, oppure un sacchetto con grani di sale per non far avvicinare la Janara: la strega, infatti,costretta a contare i fili della scopa, o i grani di sale, avrebbe indugiato fino al sorgere del sole, la cui luce pare fosse sua mortale nemica. Secondo la tradizione, per poterla acciuffare, bisognava afferrarla per i capelli, il suo punto debole e se si riusciva a catturare la Janara, ella, in cambio della libertà, avrebbe offerto la protezione delle Janare sulla famiglia per sette generazioni.
Il racconto di questo mondo simbolico, misterioso e magico, avviene all’interno di “ Janua – Il Museo delle Streghe di Benevento”, una mostra che è allocata presso alcune delle sale poste al piano terra di “Palazzo Paolo V” che si sviluppa attraverso racconti, testimonianze, documenti e rituali antichi e moderni
| ORARIO | PREZZO |
Ottobre-Maggio:Mercoledì-Domenica:
| Intero: €4 |
Giugno-settembre: Mercoledì-Domenica:
| Ridotto: €2 per:
|
Gratuito per:
|
Basilica di San Bartolomeo
Posizione e origine del nome.La basilica di San Bartolomeo sorge lungo il centralissimo corso Garibaldi. La chiesa è intitolata a San Bartolomeo, patrono della città, e sotto all’altare maggiore ne sono conservate le reliquie in un’urna di porfido.
Storia. Il primo tempio cittadino dedicato a san Bartolomeo sorgeva vicino al Duomo di Benevento ed era un piccolo edificio votivo voluto dal principe longobardo Sicardo di Benevento per custodire le spoglie di San Bartolomeo, trasferite da Lipari a Benevento. Nel 1122 l’arcivescovo Landolfo fece erigere una nuova costruzione, più imponente e separata dalla cattedrale, nell’attuale piazza Orsini, tipicamente romanica ossia a pianta centrale con marmi policromi ed il pavimento cosmatesco, elementi riemersi dai recenti scavi archeologici. La chiesa venne distrutta da sisma del 1688, poi ricostruita e nuovamente distrutta dal terremoto del 1702.

Orsini, salito al pontificato con il nome di Benedetto XIII, nel 1726 fece ricostruire la chiesa attuale nel luogo che la ospita ancora attualmente.
Struttura. Essa presenta una facciata lineare a due ordini il cui ordine superiore timpanato è raccordato a quello inferiore con due volute, ornamento geometrico a forma di spirale. Ai lati della porta si possono notare due frammenti di rilievo romanico, unica testimonianza della basilica originale.
L’interno è a una sola navata coperta da volta a botte decorata a stucchi e due cappelle su ciascun lato, arricchite da numerose opere.
| ORARIO | PREZZO |
Lunedì-Sabato:
| Ingresso: gratuito |
Domenica:
|
Cattedrale/Duomo
Storia. E’ una costruzione di matrice longobarda, consacrata nel 780 e intitolata a Sancta Maria de Episcopio. Nel corso dei secoli è stata, però, ripetutamente rimaneggiata per:
- ampliare il complesso dell’antica chiesa, oggi trasformata in cripta (XII e XVII sec.);
- riparare i danni subiti con i diversi terremoti susseguitisi (1456, 1688, 1702).

Infine, venne gravemente danneggiata dai bombardamenti angloamericani del 1943 e solo a partire dall’anno 1950 si avviò la ricostruzione, i cui lavori durarono un decennio a cui si aggiunse un ulteriore quinquennio per l’arredo.
Struttura. Nel momento in cui fu colpita, l’antica cattedrale beneventana presentava una facciata romanica e gli elementi superstiti sono stati restaurati e riutilizzati:
- la facciata che si sviluppa su due ordini suddivisi in sei arcate ed è realizzata in marmo bianco, di matrice pisana;
- la grande porta bronzea, la così detta Janua Major, composta da 72 formelle a bassorilievo, solo da qualche anno restaurata e rimessa in opera, in posizione arretrata rispetto all’originale collocazione;
- il campanile quadrato, caratterizzato da blocchi di pietra bianca, si sviluppa su due piani, separati da un cornicione sporgente. Molti elementi di spoglio romani sono incassati su tutta la sua superficie, tra cui spiccano una serie di rilievi funerariI, un leone gradiente di granito rosa, e soprattutto un cinghiale (secondo altri un maiale) stolato e cinto da una corona di alloro, pronto per il sacrificio, da cui è derivato lo stemma della città di Benevento;
- la pseudocripta che originariamente era una chiesa e, poi, in epoca successiva, venendosi a trovare al di sotto del livello dell’attuale Cattedrale, è stata trasformata in cripta. Essa consta di due navate allineate in senso trasversale rispetto all’abside.
| ORARIO | PREZZO |
Lunedì-Domenica:
| Ingresso: gratuito. |
Basilica della Madonna delle Grazie
Storia. Il culto della Madonna delle Grazie fu importato nella città di Benevento nel 570 da Sant’Artelaide, nipote di Narsete. La santa, morta sedicenne, era stata tumulata nella chiesa di San Luca, che fu poi ribattezzata a suo nome e per secoli fu molto venerata a Benevento, finché, a causa del terremoto del 1688 questa chiesa crollò. foto
Nel 1837 il Comune decise la costruzione della Chiesa della Madonna delle Grazie, quale ringraziamento per aver liberato la città dall’epidemia di colera del 1836-’37. Nel 1839 fu posta la prima pietra da monsignor Gioacchino Pecci, il futuro papa Leone XIII e venne consacrata nel 1901.
Struttura. La chiesa è di chiara ispirazione neoclassica con:

- La facciata caratterizzata da un pronao esastilo con architrave, coronato dalle statue dei sei santi di Benevento: Sant’Antonio, San Barbato, San Francesco, San Bartolomeo, San Gennaro e San Rocco;
- L’interno presenta una pianta a croce greca con cupola centrale.
| ORARIO | PREZZO |
Lunedì-Domenica:
| ingresso: gratuito. |

Lascia un commento